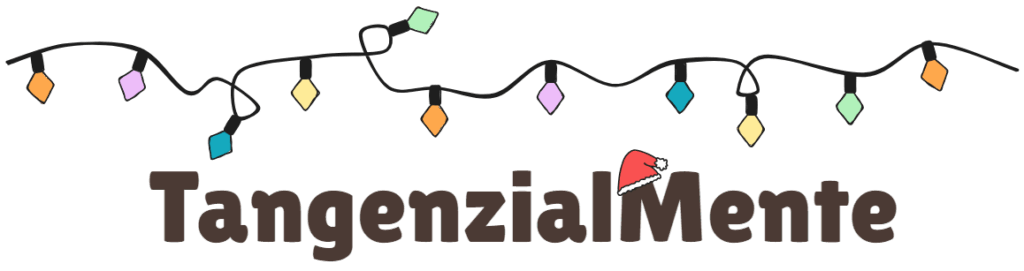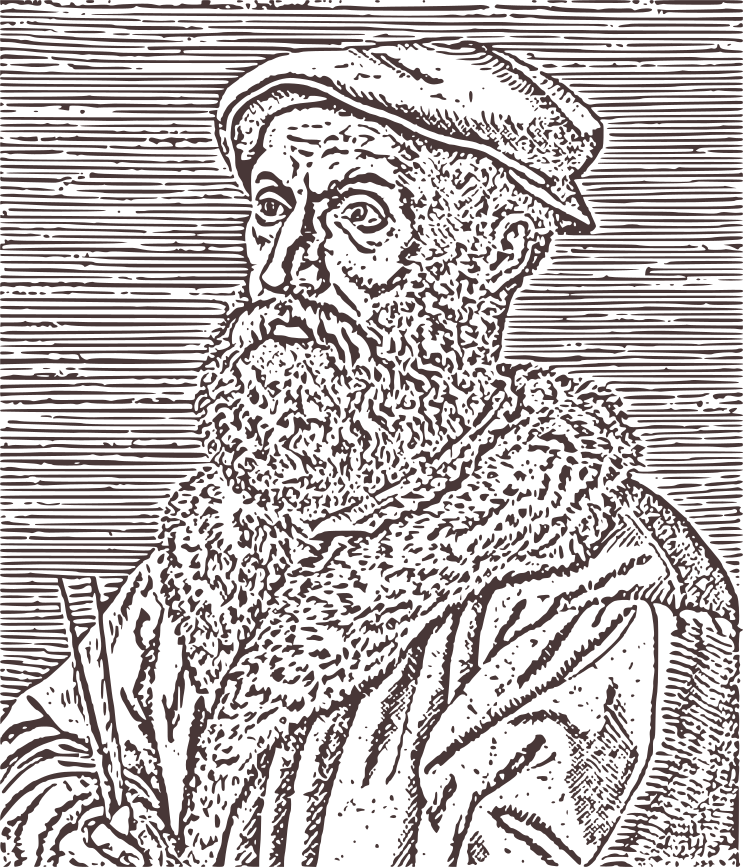La storia dietro la formula cubica
Tartaglia fu il primo a trovare una soluzione generale per l’equazione cubica, un risultato che segna una tappa chiave nella storia dell’algebra. Ma perché scelse di trasformare la sua formula in una poesia misteriosa?
Nel 1512, durante il sacco di Brescia, il dodicenne Niccolò Fontana fu gravemente ferito al viso da un colpo di sciabola. Questa ferita lo segnò per sempre, lasciandogli un grave difetto di pronuncia. Per questo, i suoi coetanei iniziarono a chiamarlo ‘Tartaglia’, che in veneziano vuol dire ‘balbuziente’ — il nome con il quale sarebbe passato alla storia.
Nonostante la sfortuna, Tartaglia divenne uno dei matematici più brillanti del Rinascimento. Il 12 febbraio 1535 riuscì a risolvere un problema che aveva fatto impazzire gli scienziati per secoli: trovò infatti il modo di risolvere le cosiddette equazioni cubiche. La sua scoperta, insieme a quelle di altri matematici della sua epoca, fu una tappa importantissima in una lunga catena di scoperte che avrebbero cambiato per sempre la matematica. Più avanti vedremo come, partendo da qui, si arrivò poco a poco alle idee rivoluzionarie di Galois e alla matematica moderna!
Cos’è un’equazione cubica?
Ma che cosa sono le equazioni cubiche? In parole semplici, sono quelle in cui la lettera (x) (il numero che dobbiamo trovare) compare “al cubo”, ovvero elevata alla terza potenza: (x^3).
Ecco un esempio: (x^3 + 5x = 2).
Le equazioni cubiche sono più difficili di quelle che di solito si fanno a scuola, dove la \(x\) appare solo al quadrato (cioè con l’esponente 2, come in \(x^2\)). Per tanti secoli nessuno era riuscito a trovare una regola generale per risolverle.
Nel grafico qui sotto puoi vedere come si disegna una tipica equazione cubica:

Le terzine di Tartaglia
All’epoca, il linguaggio matematico moderno non esisteva ancora, e solo pochi in Europa avevano iniziato ad usare simboli matematici. Tartaglia quindi, come molti altri, descrisse la sua scoperta usando solo parole! E non solo — per ricordare la formula più facilmente, la espresse in forma poetica usando le terzine:
Formula delle equazioni cubiche
Quando chel cubo con le cose appresso
Se agguaglia à qualche numero discreto
Trouan dui altri differenti in esso.
Dapoi terrai questo per consueto
Che’llor produtto sempre sia eguale
Al terzo cubo delle cose neto,
El residuo poi suo generale
Delli lor lati cubi ben sottratti
Varra la tua cosa principale.
In el secondo de cotesti atti
Quando che ‘l cubo restasse lui solo
Tu osseruarai quest’altri contratti,
Del numer farai due tal part’à uolo
Che l’una in l’altra si produca schietto
El terzo cubo delle cose in stolo
Delle qual poi, per commun precetto
Torrai li lati cubi insieme gionti
Et cotal somma sara il tuo concetto.
El terzo poi de questi nostri conti
Se solue col secondo se ben guardi
Che per natura son quasi congionti.
Questi trouai, & non con paßi tardi
Nel mille cinquecent’e, quatro e trenta
Con fondamenti ben sald’e gagliardi
Nella citta dal mar’intorno centa.
Fonte: WikiSource
Questa spiegazione in rima, per quanto accattivante, risulta piuttosto complessa da comprendere per noi lettori moderni. Oggi, infatti, scriviamo la stessa formula in un modo completamente diverso:
$$x = \sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{ \frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} – \sqrt[3]{- \frac{q}{2} – \sqrt{ \frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$$
A un primo sguardo questa formula ci può sembrare complicata ma, almeno per i matematici moderni, questa notazione risulta molto più chiara e universale della descrizione in versi.
Per il nostro amico Tartaglia, invece, era normale esprimere i concetti matematici in parole. Per esempio:
- \(x\) era chiamato “cosa”
- \(x^2\) era chiamato “censo”
- \(x^3\) era chiamato “cubo”
L’equazione \(x^2 + 2x = 11\) poteva infatti essere scritta come:
‘Un censo più due cose sono equivalenti a undici unità.’
Attività
Risolvete queste equazioni scritte in parole:
- Un numero più due è uguale a cinque.
- Il quadrato di un numero, diminuito di tre volte il numero stesso, è uguale a quattro.
- Un numero, sommato al suo triplo, dà come risultato dieci.
- Due censi più tre cose sono equivalenti a ventuno unità.
L’impatto della scoperta
La scoperta di Tartaglia era rivoluzionaria per il suo tempo. Era il primo grande passo avanti in algebra dai tempi degli antichi babilonesi, che avevano trovato come risolvere le equazioni di secondo grado usando un metodo equivalente alla formula che impariamo a scuola:
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 – 4ac}}{2a}$$
Più tardi, la formula delle equazioni cubiche di Tartaglia porterà al riconoscimento dell’utilità delle radici di numeri negativi e quindi alla scoperta dei numeri complessi.
Tartaglia e Cardano: Formule segrete e tradimenti matematici

La storia ha una fine poco gloriosa. Tartaglia aveva condiviso la sua formula con Gerolamo Cardano, un famoso matematico dell’epoca. Anni dopo, Cardano pubblicò la soluzione nel suo libro Ars Magna (1545), nonostante avesse giurato a Tartaglia di non rivelarla mai ad anima viva…
Cardano aveva però scoperto che un altro matematico, Scipione Dal Ferro, aveva trovato la stessa formula circa vent’anni prima di Tartaglia. Dal Ferro la tenne segreta, condividendola solo con pochi fidati prima di morire nel 1526.
Cardano venne a sapere di Dal Ferro durante un viaggio a Bologna, dove vide i suoi vecchi appunti. Ritenne quindi opportuno pubblicare la formula, senza il consenso di Tartaglia, visto che stava rivelando la scoperta di qualcun altro.
Tartaglia, tuttavia, si sentì tradito e questo scatenò una feroce disputa tra i due che durò per il resto delle loro vite.
Cosa è successo dopo?

La formula per le equazioni cubiche fu solo l’inizio di una serie di scoperte matematiche entusiasmanti.
Poco dopo infatti, Ludovico Ferrari, un allievo di Cardano, trovò un modo per risolvere le equazioni di quarto grado. Ma qui le cose si complicarono.
Per quasi tre secoli, i matematici cercarono senza successo una formula simile per le equazioni di quinto grado. La svolta arrivò nel XIX secolo, ma non come ci si aspettava.
Nel 1832, il giovane matematico francese Évariste Galois dimostrò che non può esistere una formula generale per risolvere le equazioni di grado superiore al quarto usando solo operazioni algebriche e radici. Incredibilmente, Galois fece questa scoperta rivoluzionaria prima di morire tragicamente all’età di soli 20 anni, in seguito a un duello. La notte prima dello scontro fatale, consapevole del pericolo, passò le ore a scrivere freneticamente i suoi risultati matematici.
La dimostrazione di Galois non solo chiuse la ricerca di una formula per le equazioni di quinto grado, ma aprì anche una nuova e potente branca della matematica: la teoria dei gruppi.
Il lavoro di Galois, nonostante la sua breve vita, gettò le basi per l’algebra astratta moderna, influenzando profondamente lo sviluppo della matematica nei secoli successivi.
Così, da un problema apparentemente specifico come la risoluzione delle equazioni cubiche, si è sviluppata una catena di scoperte che ha cambiato la nostra comprensione dell’algebra e della matematica in generale.
Riflessioni sulla notazione matematica
Dopo aver visto la storia di Tartaglia e l’evoluzione dalla poesia alla formula moderna, possiamo chiederci: perché usiamo la notazione matematica che usiamo oggi?
Attività
Scegliete una formula matematica e riscrivetela in poesia.
Il ruolo della memoria
Tartaglia stesso scrisse di aver messo la formula in rima per ricordarla meglio:
Voglio che sappiati che per potermi aricordare in ogni mia improvisa occorrentia tal modo operativo, io l’ho redutto in uno capitolo in rima, perché se io non havessi usato questa cautella, spesso me saria uscito di mente. Et quantunque tal mio dire in rima non sia molto terso, non mi ho curato, perché mi basta che mi serva a ridurme in memoria tal regola ogni volta che io il dica.
In italiano moderno, Tartaglia sta dicendo: “Voglio che sappiate che per potermi ricordare questo metodo in ogni occasione improvvisa, l’ho ridotto in un capitolo in rima, perché se non avessi usato questa precauzione, spesso mi sarebbe uscito di mente. E anche se il mio modo di dire in rima non è molto elegante, non me ne sono curato, perché mi basta che mi serva a ricordare questa regola ogni volta che lo recito.”
Domanda
Quale versione trovate più facile da ricordare, le terzine o la formula moderna? Perché?
È vero che ricordare una poesia è facilitato molto dal ritmo e dalla rima. Tuttavia, questo era più importante nei tempi passati. Ricordare le formule in parole è, forse, ancora più difficile che ricordare i simboli. Personalmente, quando mi ricordo una formula come questa:
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 – 4ac}}{2a}$$
mi ricordo soprattutto la forma o “l’immagine” dell’equazione. La forma visiva è spesso la più immediata e più facile da capire. Questo aiuta la comprensione e quindi la memoria.
Per esempio, in questa formula, la struttura visiva con la frazione, il segno $\pm$ e la radice quadrata crea un’immagine mentale distintiva. Questa “forma” dell’equazione può essere più facile da ricordare rispetto a una descrizione verbale.
Un’altra cosa importante è il fatto che al tempo di Tartaglia i libri stampati erano una rarità, e la memoria era praticamente l’unico strumento a disposizione.
Oggi invece siamo all’altro estremo: è talmente facile ritrovare delle informazioni che spesso non le scriviamo nemmeno.
C’è anche da dire che l’effetto aggiuntivo artistico rende la formula più appetibile alla mente umana, e quindi più permanente nella memoria. Questo aspetto “poetico” della matematica non è completamente perso nella notazione moderna, ma si manifesta in modi diversi, come nell’eleganza e nella simmetria di certe equazioni.
Domanda
La matematica perde qualcosa di “poetico” con la notazione moderna?
È anche curioso vedere come il modo di insegnare la matematica sia cambiato nel tempo da questo punto di vista. Una volta, si dava molta importanza a imparare le cose a memoria. Oggi invece si punta di più a capire i concetti e a saperli usare. Ci sono due motivi principali per questo cambiamento. Primo, secondo le idee pedagogiche moderne è più utile insegnare a ragionare e a capire le cose in profondità. Secondo, oggi abbiamo sempre il telefono in tasca con tutte le informazioni a portata di mano, quindi ricordare tutto a memoria non è più così importante come una volta.
Questo non vuol dire che la memoria non serva più. Per alcune formule importanti vale ancora la pena sforzarsi di impararle. Per questo, gli insegnanti usano spesso dei trucchetti per aiutare gli studenti a ricordare le cose fondamentali. L’idea è di trovare un equilibrio tra ricordare le cose importanti e capire veramente come funzionano.
Chiarezza e precisione
La notazione matematica che usiamo oggi ha dei vantaggi significativi rispetto alle descrizioni in parole come quelle di Tartaglia. Ma è davvero più chiara per tutti?
Domanda
Quale versione trovate più facile da capire, le terzine di Tartaglia o la formula moderna? Perché?
La notazione matematica moderna ha alcuni punti di forza:
- È concisa: può esprimere idee complesse in poco spazio.
- È precisa: riduce le ambiguità che possono nascere con le parole.
- È visiva: spesso la forma di un’equazione ci dice molto sul suo significato.
- È universale: i matematici di tutto il mondo la capiscono, indipendentemente dalla loro lingua madre.
Tuttavia, non è priva di svantaggi:
- Può sembrare astratta e difficile da interpretare per chi non è abituato.
- Perde parte del fascino poetico che troviamo nelle descrizioni verbali come quelle di Tartaglia.
- In alcuni casi, può creare barriere culturali. Per esempio, i libri cinesi e giapponesi sono normalmente scritti in verticale, ma i testi scientifici devono essere scritti in orizzontale per poter usare le notazioni matematiche “universali” sviluppate in occidente.
Domanda
Cosa rende una notazione matematica “buona” o “utile”? È la facilità con cui si può scrivere? O quanto è comprensibile per chi la vede per la prima volta? O forse quanto è versatile per esprimere idee diverse?
Attività
Inventate una vostra notazione per un’equazione semplice come “un numero più due è uguale a cinque”. Per esempio:
“num. add. II fa V”
Poi confrontatela con quella dei vostri amici. Chiedetevi a questo punto se il vostro sistema è chiaro, conciso e facile da usare.
Evoluzione della notazione matematica
La notazione matematica che usiamo oggi è il risultato di secoli di evoluzione. Come abbiamo visto, nell’antichità e nel Rinascimento, la matematica veniva scritta principalmente in parole.
Nel XVI secolo, matematici come François Viète iniziarono a usare lettere per rappresentare numeri sconosciuti. Questo fu un grande passo avanti. Gradualmente, la notazione divenne sempre più standardizzata. Simboli come +, -, ×, ÷ diventarono comuni. Nel XVIII e XIX secolo, con lo sviluppo di nuovi campi della matematica come il calcolo e l’algebra astratta, vennero introdotti nuovi simboli e notazioni.
Oggi, la notazione matematica continua a evolversi. Nuovi campi come la teoria dei grafi o la logica matematica hanno le loro notazioni specializzate. E con l’avvento dei computer, sono nate nuove forme di rappresentazione matematica, come i linguaggi di programmazione matematica.
La matematica non è solo un insieme di regole fisse, ma un linguaggio vivo che si adatta alle nuove idee e alle nuove sfide. La notazione che usiamo oggi ci permette di esprimere concetti complessi in modo chiaro e conciso, ma chissà come scriveremo la matematica tra cento anni!
Domanda
Sarebbe stato possibile fare certe scoperte matematiche senza una notazione adeguata?
Risorse
- Cardano, Tartaglia e la formula contesa: Un articolo dettagliato sulla scoperta di Tartaglia e sulla lunga disputa con Cardano.
- Il testo originale della poesia di Tartaglia (WikiSource): La poesia completa in cui Tartaglia codificò la sua famosa formula.
Ringraziamenti
Grazie ad Andrea per avermi parlato di questo argomento e per le utili spiegazioni che mi ha dato.