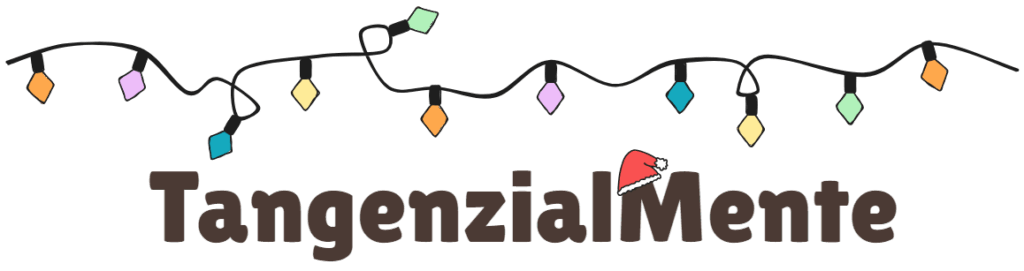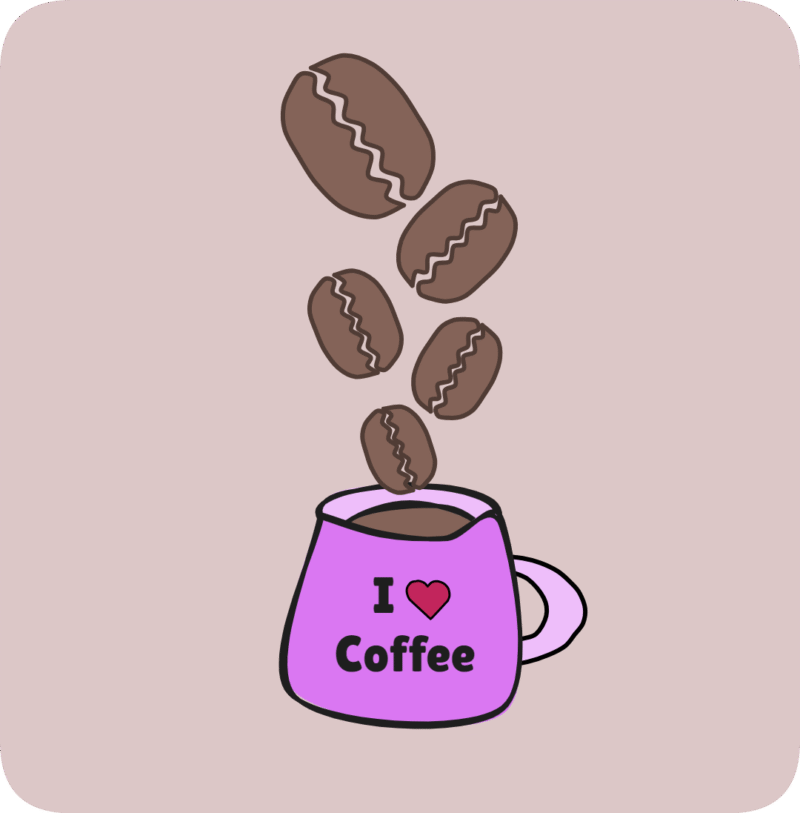Storia e curiosità sulla bevanda più amata al mondo
Etiopia, tanti secoli fa, sulle colline della regione di Kaffa. È una mattina come tante, ma Kaldi, giovane pastore, si accorge subito che c’è qualcosa di strano: il suo gregge di capre sembra posseduto! Saltano, si rincorrono, belano così forte che persino le altre greggi si girano a guardare… Alcune capre eccitate tentano persino di formare una specie di piramide traballante. “Non ho mai visto nulla del genere!”, pensa Kaldi, mentre cerca di acchiappare una capretta che saltella come se avesse le molle sotto gli zoccoli. Anche la capra più timida, quella che di solito si nasconde dietro le altre, oggi è scatenata: sta addirittura cercando di salire su un cespuglio pieno di bacche rosse e brillanti!
Kaldi si avvicina e sente un profumo strano nell’aria, mai sentito prima: qualcosa di caldo, terroso, quasi dolce, ma che pizzica un po’ il naso. “E se fosse tutta colpa di queste bacche misteriose?”, si chiede.
Chissà se Kaldi avrebbe mai potuto immaginare che, molti anni dopo, quel profumo avrebbe accompagnato le mattine di milioni di persone in tutto il mondo.
Così, secondo la leggenda, è iniziata la storia del caffè…
Ti sei mai chiesto perché così tante persone sembrano non poter iniziare la giornata senza quella tazzina fumante? O perché in tutto il mondo, da New York a Tokyo, da Milano a Rio de Janeiro, milioni di persone si ritrovano davanti a questa bevanda scura e aromatica?
La leggenda di Kaldi è la più famosa sull’origine del caffè. Che sia vera o no, ci racconta che il caffè ha un potere speciale sugli esseri viventi. Questo potere è legato alla caffeina, la sostanza che conferisce al caffè la sua unicità, responsabile degli effetti — sia benefici che avversi — che questa bevanda esercita sul nostro organismo.
La chimica nella tazzina
Quello che le capre di Kaldi scoprirono per caso è un effetto che oggi conosciamo bene: la caffeina è uno stimolante. Ma cosa succede esattamente nel nostro corpo quando beviamo un caffè?

La caffeina è una molecola furba: assomiglia a una sostanza chiamata adenosina, che normalmente ci fa sentire stanchi. Quando beviamo caffè, la caffeina si attacca ai recettori che solitamente accolgono l’adenosina, bloccandoli. Risultato? Il nostro cervello non riceve il messaggio “sono stanco” e ci sentiamo più svegli e attivi.
Domanda
Hai mai notato cambiamenti nel tuo corpo dopo aver bevuto una bevanda contenente caffeina, come il caffè, bevande energetiche o alcuni tipi di tè? Prova a osservare se ti senti più attento, se il tuo cuore batte più velocemente o se hai più energia!
Come prepari il caffè a casa? Chicchi, macinato, capsule
Hai mai visto qualcuno discutere animatamente su quale caffè comprare? Chicchi interi, macinato o in capsule: cosa significa questa scelta nella pratica?
Perché il caffè in chicchi è il campione della freschezza
Il segreto di un buon caffè è racchiuso nei suoi aromi, e i chicchi interi sono come scatole sigillate che proteggono questi tesori aromatici. Il caffè in chicchi conserva la freschezza molto più a lungo rispetto a quello già macinato. Questo perché, una volta macinato, gli oli essenziali e le sostanze aromatiche esposte all’aria iniziano subito a ossidarsi e a perdere intensità.
Se vuoi il massimo della freschezza, la soluzione ideale sarebbe macinare i chicchi poco prima di preparare il caffè. È come paragonare il pane appena sfornato con uno di tre giorni fa!
Ma per un caffè “al volo”, questa soluzione può sembrare troppo laboriosa. Per questo motivo molti preferiscono il caffè già macinato o quello in capsule, per semplificare la preparazione.
Vantaggi e svantaggi: la battaglia delle tre preparazioni
Ogni formato ha quindi i suoi pro e contro:
Caffè in chicchi
- Vantaggi: massima freschezza, controllo sulla macinatura, minor imballaggio, esperienza sensoriale completa
- Svantaggi: richiede un macinino, tempo di preparazione maggiore, più difficile da trovare
Caffè macinato
- Vantaggi: praticità, nessun bisogno di macinino, ampia disponibilità
- Svantaggi: perde freschezza rapidamente, meno controllo sulla preparazione
Capsule
- Vantaggi: velocissime, consistenza del risultato, pulizia immediata
- Svantaggi: costo elevato, impatto ambientale notevole, meno freschezza
Sfida
Quante tazzine di caffè pensi vengano consumate ogni giorno in Italia? Prova a indovinare!
Risposta
95 Milioni
Salvare il pianeta, un chicco alla volta
Se anche tu sei preoccupato per l’ambiente, la scelta è piuttosto chiara: il caffè in chicchi è la soluzione più ecologica! Richiede meno imballaggi ed è meno processato rispetto al caffè macinato. Le capsule, al contrario, sono spesso difficili da riciclare e creano una grande quantità di rifiuti, a meno che non si scelgano quelle compostabili.
Che cos’è il caffè decaffeinato?
Il caffè è famoso per il suo effetto stimolante, ma in realtà molte persone lo bevono soprattutto per l’aroma e il gusto. C’è anche chi preferisce godersi una tazza di caffè senza gli effetti della caffeina, magari la sera o perché è più sensibile a questa sostanza: per questo nasce il caffè decaffeinato.
Box Approfondimento
Storia del decaffeinato
Il primo caffè decaffeinato risale ai primi del Novecento e si deve al commerciante tedesco Ludwig Roselius, fondatore della Kaffee HAG. Secondo la leggenda, tutto iniziò quando una partita di chicchi di caffè si bagnò accidentalmente con acqua salata durante un viaggio in nave. Roselius notò che la caffeina era in parte scomparsa, ma il sapore era rimasto quasi lo stesso. Da qui, nel 1905, venne sviluppato il primo metodo industriale di decaffeinizzazione, che prevedeva l’uso di vapore e benzene per eliminare la caffeina. Col tempo, il benzene è stato abbandonato perché dannoso per la salute, e oggi si usano metodi più sicuri, come l’anidride carbonica o l’acqua. Il caffè decaffeinato in produzione oggi sembra non essere particolarmente pericoloso, anche se alcuni aspetti rimangono ancora da chiarire nella ricerca scientifica.
La notizia sorprendente? Il caffè decaffeinato, in realtà, non è completamente “senza caffeina”! Anche se sulla confezione c’è scritto “decaffeinato”, una minuscola quantità di caffeina rimane sempre. Infatti, eliminare il 100% della caffeina da un chicco di caffè è praticamente impossibile con i metodi che abbiamo oggi.
In Europa, le regole sono molto rigide: il decaffeinato può contenere solo una quantità davvero piccola di caffeina (spesso meno dello 0,1% nei chicchi torrefatti). Negli Stati Uniti, invece, i limiti sono un po’ più rilassati – così, nella pratica, una tazza decaffeinata americana potrebbe avere un po’ più caffeina rispetto a una europea.
Quindi se stai cercando di eliminare del tutto la caffeina – magari perché sei molto sensibile o per esigenze particolari di salute – sappi che il decaffeinato non è una soluzione magica, anche se la quantità di caffeina rimanente è davvero bassa.
Ha senso bere un caffè senza caffeina? Per chi soffre di pressione alta, oppure per chi vuole gustarsi un espresso anche di sera senza rischiare di restare sveglio, il decaffeinato è una scelta perfetta. Per altri, togliere la caffeina dal caffè è quasi come togliere la musica da un concerto!
Anche se qualcuno dice che il gusto non sia proprio identico al caffè classico, il mercato del decaffeinato è in forte crescita in tutto il mondo. Si stima che il mercato globale del caffè decaffeinato raddoppierà entro 10 anni.
Cosa sono esattamente i chicchi di caffè?
Quello che chiamiamo “chicco di caffè” in realtà è un seme! Le piante di caffè sono piccoli alberi che possono raggiungere i 3-4 metri di altezza, e i chicchi sono proprio i semi di questi alberi. Ogni chicco contiene infatti tutto il necessario per far nascere una nuova pianta di caffè.

Un arbusto di caffè in media produce 1/1.5 Kg di chicchi all’anno.
I semi crescono all’interno di bacche rosse che assomigliano a ciliegie, chiamate “drupe”. Ogni bacca contiene generalmente due semi, attaccati l’uno all’altro — questo gli conferisce la classica forma tondeggiante da un lato e piatta dall’altro. I frutti maturi vengono raccolti — normalmente a mano — e poi lavorati in appositi macchinari che ne estraggono i semi.
Curiosità
In alcune regioni dell’Indonesia, i chicchi di caffè vengono fermentati nello stomaco di un piccolo mammifero chiamato zibetto, poi raccolti dai suoi escrementi, creando il costosissimo Kopi Luwak!
Perché i chicchi vengono tostati?
I chicchi freschi appena raccolti non sono marroni, ma verdi! Non hanno ancora quell’aroma meraviglioso che conosciamo, e la vera magia avviene durante la tostatura (o torrefazione). Se potessi osservare i chicchi mentre si tostano, vedresti un vero spettacolo! Quando i chicchi verdi vengono riscaldati a temperature tra i 190 e i 220 gradi, scoppiano con un suono simile al popcorn (anche se più delicato), si gonfiano e rilasciano un fumo profumato. I maestri tostatori sanno esattamente quando fermare il processo per ottenere diverse intensità di sapore: più la tostatura è lunga, più il caffè sarà forte e amaro.
Durante il processo di tostatura, i chicchi:
- Cambiano colore, passando dal verde al giallo dorato fino al marrone scuro
- Aumentano di volume, arrivando anche al doppio della dimensione originale, un po’ come i popcorn
- Diventano più friabili e facili da macinare
- Sviluppano molti composti aromatici diversi, che creano quel profumo irresistibile

Curiosità
Nella storia di Kaldi che abbiamo raccontato all’inizio dell’articolo c’è un’imprecisione: la pianta del caffè, infatti, non ha affatto il tipico odore della bevanda che conosciamo! È solo dopo la tostatura che i chicchi sviluppano l’aroma.
Varietà: Un mondo di caffè
Esistono più di 100 specie di piante di caffè, ma solo due sono responsabili per quasi tutto il caffè che beviamo: l’Arabica e la Robusta.
Arabica: la regina delicata
La varietà Arabica rappresenta circa due terzi della produzione mondiale di caffè, ed è spesso considerata la migliore. Ha bisogno di condizioni perfette per dare il meglio di sé: originaria degli altopiani dell’Etiopia, preferisce l’ombra, le temperature non troppo alte (circa 20 gradi) e cresce a un’altitudine che può arrivare fino a 2800 metri! Questo tipo di caffè è delicato, dolce, con aromi fruttati ed equilibrati. Questa è probabilmente stata la prima varietà ad essere coltivata.
Robusta: la guerriera instancabile
Come suggerisce il nome, questa varietà è robusta davvero! Cresce più velocemente dell’Arabica, resiste meglio ai parassiti e alle malattie, e può adattarsi a climi più vari. Il suo sapore è più intenso, meno profumato e più amaro. La Robusta contiene quasi il doppio di caffeina rispetto all’Arabica e, grazie alla sua forza, spesso viene utilizzata nelle miscele per dare più corpo all’espresso e una “sveglia” più decisa. Ma viene utilizzata anche semplicemente perché, grazie alla facilità di coltivazione, è meno costosa dell’Arabica!
Domanda
Qual è la varietà che ti ispira di più, e perché? Se potessi inventarne una nuova, che caratteristiche avrebbe?
Come il caffè è diventato la bevanda delle colazioni?
Facciamo un passo indietro: il caffè come lo conosciamo oggi può sembrare qualcosa di comune, ma ha fatto un viaggio incredibile attraverso i secoli e i continenti! E non parliamo solo dei chicchi, ma di tutta la cultura che si è sviluppata attorno a questa bevanda.
Kaldi sarà forse solo un bel racconto, ma l’Etiopia è davvero il luogo dove il caffè cresce spontaneamente da millenni. In particolare nella regione di Kaffa, che molti pensano sia all’origine del nome “caffè”. All’inizio, le piante del caffè erano probabilmente coltivate per i loro frutti e per gli infusi che si facevano con le loro foglie — solo dopo abbiamo scoperto il valore dei loro semi!
Altri studiosi dicono che il nome caffè non viene dalla regione di Kaffa, bensì dalla parola araba qahwa. Infatti i primi a utilizzare sistematicamente i chicchi di caffè furono probabilmente gli arabi, che portarono le bacche dall’Etiopia allo Yemen intorno al XV secolo. Ben presto, i Sufi dello Yemen iniziarono ad usarle per rimanere svegli durante le preghiere notturne, e la bevanda si diffuse anche a La Mecca e in tutto il mondo arabo, dove sono comparse le prime caffetterie. La moda del caffè raggiunse persino la famiglia reale ottomana — il kahvecibaşı (“capo caffettiere”) era un personaggio molto importante della corte del sultano!
Finalmente il caffè partì dall’Africa, attraversando il mar Rosso e passando di mano in mano tra mercanti e viaggiatori, per arrivare a Venezia nel Seicento. In Italia lo chiamavano “vino d’Arabia”, e molti rappresentanti della Chiesa guardavano con sospetto questa bevanda sconosciuta tanto da considerarla la “bevanda del diavolo”, forse perché il suo effetto energizzante sembrava quasi magico o sospetto.
Ma il vero colpo di scena avvenne quando Papa Clemente VIII decise di assaggiare il misterioso caffè. Si racconta che, dopo aver sorseggiato la famosa “bevanda del diavolo”, abbia esclamato: «Questa bevanda di Satana è così deliziosa che sarebbe un peccato lasciarne l’uso esclusivo agli infedeli!» Così, anziché vietarla, il Papa la benedisse, probabilmente anche perché la riteneva migliore del vino e della birra per il popolo dell’epoca.
Domanda
Conosci altre bevande o altri cibi che hanno fatto viaggi incredibili attraverso continenti e culture prima di arrivare sulla nostra tavola?
Sfida
Ogni cultura ha la sua parola per “caffè”. Alcuni esempi includono qahwa in arabo e café in francese. Cerca come viene chiamato il caffè in altre 3 lingue. Perché pensi che queste parole siano così simili tra loro nonostante provengano da culture diverse?
Come si preparava il caffè originariamente?
La preparazione “alla turca” è una delle più antiche e affascinanti, e ancora oggi viene usata dal Medio Oriente ai Balcani fino al Caucaso. Si prepara mettendo acqua e caffè macinato (spesso anche zucchero e, se vuoi, spezie come il cardamomo) in un piccolo bricco di rame chiamato cezve. Dopo aver mescolato bene, si lascia scaldare sul fuoco finché non sale una densa schiuma in superficie. Attenzione: il caffè non si filtra! Per gustarlo bisogna aspettare che la polvere si depositi sul fondo della tazza. In alcuni paesi, questa tradizione diventa anche una specie di gioco: il fondo della tazza viene “letto” per predire il futuro!

Ricetta: Caffè turco (nel pentolino)
Ti servono:
- 1 tazza d’acqua fredda (circa 100 ml)
- 1 cucchiaino abbondante di caffè macinato molto fine (tipo polvere per espresso)
- Zucchero a piacere (opzionale)
- Un pizzico di spezie (come il cardamomo) se ti piace sperimentare
- Un piccolo pentolino (meglio se con il fondo spesso)
- Un cucchiaino
Come fare:
- Aspetta un minuto che la polvere si depositi sul fondo, poi gusta!
- Versa l’acqua nel pentolino.
- Aggiungi il caffè (e lo zucchero e le spezie, se vuoi).
- Accendi il fuoco basso e mescola piano fino a ottenere un composto omogeneo.
- Lascia scaldare: appena il caffè inizia a schiumare e a “salire” (compariranno delle bolle e una schiuma densa in superficie), togli il pentolino dal fuoco prima che bolla del tutto.
- Rimetti sul fuoco per un attimo, solo per far “salire” ancora la schiuma, poi togli di nuovo.
- Versa piano il caffè nella tazzina, cercando di fare uscire più schiuma possibile.
Da Napoli a Torino, fino a casa tua
Con il tempo, il caffè ha trovato tanti modi diversi per essere preparato, e l’Italia ha dato un contributo fondamentale. Ma c’è una curiosità che forse non tutti conoscono: la famosa caffettiera napoletana non è nata in Italia! La sua storia inizia all’inizio dell’Ottocento in Francia, dove lo stagnino Jean-Louis Morize brevettò nel 1820 un modello ad “inversione” fatto di rame, perfetto per preparare il caffè senza farlo bollire. L’acqua scorreva dall’alto, passando lentamente attraverso il caffè macinato. Questa invenzione, arrivata presto anche a Napoli, per decenni è stata protagonista nelle case italiane.

Ma, come spesso capita, la voglia di un caffè ancora più forte e veloce ha portato a nuove invenzioni. Nel 1884 nasce a Torino la prima macchina per espresso: da qui in poi, i bar si sono moltiplicati ovunque, offrendo quella bevanda cremosa e intensa che unisce la tradizione millenaria della pianta con la tecnologia moderna.
Nel 1933, Alfonso Bialetti inventò la moka: questa volta, la magia avviene sul fornello di casa. L’acqua, riscaldandosi, sale spinta dalla pressione e attraversa il caffè. Oggi, invece, sempre più famiglie utilizzano macchine per caffè in cialde: pratiche, veloci e perfette per chi ha poco tempo.
Caffè e società: quando una bevanda unisce le idee
Tra il Seicento e il Settecento, mentre il caffè conquista l’Europa, succede qualcosa di straordinario: nascono i caffè, dei veri e propri luoghi di ritrovo che cambieranno la storia delle idee!
Immagina un’epoca senza internet, senza televisione, senza radio. Come si diffondono le idee? Nei caffè! In tutta Europa, dalla Francia all’Inghilterra, i caffè letterari divennero rapidamente centri del pensiero illuminista. Erano posti dove persone di ogni classe sociale si incontravano, discutevano, leggevano giornali e scambiavano idee.
Curiosità
Sapevi che persino Johann Sebastian Bach, uno dei più grandi compositori di tutti i tempi, era affascinato dal caffè? Tra il 1732 e il 1735, Bach compose un’opera comica conosciuta come “La Cantata del caffè”. Questa mini-opera racconta la storia di Schlendrian, un padre che cerca in tutti i modi di far smettere la figlia Lieschen di bere caffè. Quando lui minaccia di non farle trovare marito se non rinuncia alla sua “dipendenza”, Lieschen sembra arrendersi. Ma in realtà si ingegna e fa inserire nel contratto di matrimonio una clausola che le permette di bere caffè ogni volta che vuole!
A Parigi, filosofi come Voltaire, Diderot e Rousseau si ritrovavano nei caffè per discutere di filosofia, politica e scienza. A Londra, anche Isaac Newton e Edmund Halley erano assidui frequentatori. A Milano, i fratelli Verri e Cesare Beccaria si incontravano nei caffè e fondarono persino una rivista chiamata “Il Caffè“.

Le conversazioni che nascevano tra quelle mura hanno cambiato il modo di pensare di intere generazioni. Molte delle idee di libertà e uguaglianza che oggi consideriamo normali sono nate proprio lì, tra un sorso e l’altro.
Domanda
Secondo te, perché proprio il caffè divenne il simbolo di questo movimento culturale, e non per esempio la birra? Cosa pensi che abbia avuto di speciale, rispetto ad altre bevande?
E se il caffè non avesse mai raggiunto l’Europa?
Proviamo a immaginare un mondo in cui il caffè non fosse mai arrivato in Europa. Senza quei caffè letterari dove le idee di libertà e uguaglianza si diffondevano, forse la Rivoluzione Francese sarebbe stata diversa, o addirittura rimandata. Le grandi discussioni scientifiche, filosofiche e politiche avrebbero trovato altri spazi per svilupparsi?
È affascinante pensare che una semplice bevanda possa aver contribuito a plasmare la società moderna!
Caffè e ambiente — il lato oscuro della tazzina
Non è tutto rose e fiori nel mondo del caffè! Quando lo prepariamo comodamente a casa, raramente pensiamo al lungo viaggio che quei chicchi hanno fatto per arrivare nella nostra tazza. Eppure, dietro ogni sorso si nascondono sfide importanti che spesso non vediamo: deforestazione, difficoltà per chi lo coltiva e cambiamenti climatici che minacciano il futuro di questa bevanda.
- Acqua: Coltivare il caffè richiede moltissima acqua, spesso sottraendola alle comunità locali che ne avrebbero bisogno per l’agricoltura o la pesca. È come se ogni tazzina portasse con sé litri e litri di acqua invisibile!
- Biodiversità: Le foreste tropicali — veri gioielli di biodiversità — vengono spesso abbattute per far spazio a nuove piantagioni. Ironicamente, gli stessi ambienti che hanno dato origine alla leggenda di Kaldi e delle sue capre danzanti oggi vengono trasformati in monocolture, causando erosione del suolo e perdita di habitat per tante specie animali e vegetali.
- Agricoltori: Dietro ogni chicco ci sono milioni di persone in tutto il mondo, soprattutto piccoli agricoltori con piantagioni inferiori a 5 ettari, che spesso vivono in condizioni precarie e dipendono dal caffè per vivere. Inoltre, i cambiamenti climatici stanno rendendo tutto ancora più difficile: secondo alcune previsioni, entro il 2050 potremmo perdere metà dei terreni adatti alla coltivazione del caffè, il che sarebbe drammatico per tante famiglie che vivono di questo lavoro.
Domanda
Sai da dove viene il caffè che hai a casa? Hai mai guardato l’etichetta per scoprirne l’origine?
Cosa possiamo fare noi?
Il problema è complesso e globale, ma possiamo comunque cercare di fare la differenza con le nostre scelte! Ecco alcune idee:
- Scegli caffè certificato “etico” o “sostenibile” (Fairtrade, biologico)
- Preferisci confezioni riciclabili o compostabili
- Limita l’uso di capsule monouso
- Ricorda che il fondi di caffè possono essere usati come fertilizzante per le piante!
- Parla del caffè sostenibile e incoraggia gli altri a scegliere marchi che rispettano l’ambiente
Un ultimo sorso
Il caffè ha una storia affascinante che attraversa secoli e continenti. Dalle capre saltellanti dell’Etiopia fino alla moka che borbotta nella tua cucina, questa bevanda ha creato culture, economie e tradizioni. Il suo valore va ben oltre il semplice gesto quotidiano di berlo: l’influenza del caffè sulla storia delle civiltà e sull’ambiente merita davvero di essere considerata.
Se c’è una cosa che mi ha stupito durante questo viaggio nel mondo del caffè, è scoprire quante storie si nascondano dietro ogni tazzina.
Sfida
La prossima volta che passi davanti a un bar, osserva quando e come le persone bevono il caffè nel tuo quartiere o nella tua città. Che storia ti svelano quei gesti quotidiani e quelle abitudini condivise?
Idee per attività didattiche
Attività pratiche
- Il diario del caffè: Per una settimana, osserva e documenta come, dove e quando le persone intorno a te bevono il caffè. Nota le differenze tra generazioni, momenti della giornata e contesti sociali. Crea una piccola “antropologia del caffè” con le tue osservazioni.
- Intervista a casa: Fai un’intervista a familiari o amici su come preparano il caffè: quale tipo usano, come lo bevono, a che ora e in quale occasione della giornata, con chi e perché.
- Confronto tra chicchi: Prendi un chicco di Arabica e uno di Robusta. Osserva le differenze nella forma, nel colore e nell’aroma. Quale ti sembra più profumato? Più scuro? Più grande?
- Storie di famiglia: Chiedi ai tuoi familiari o amici quale sia stato l’ultimo argomento “importante” che hanno discusso al bar davanti a un caffè. Raccogli le loro storie.
Matematica applicata
- Se un caffè preparato con la moka richiede 10g di caffè macinato e un pacchetto da 250g costa 5€, quanto costa una singola tazzina?
- La deforestazione per le piantagioni di caffè procede al ritmo di circa 100.000 ettari all’anno. Se un ettaro contiene mediamente 400 alberi, approssimativamente quanti alberi vengono abbattuti ogni giorno per fare spazio a nuove piantagioni?
- Se per produrre 1kg di caffè servono 18.900 litri d’acqua, quanta acqua “virtuale” consuma una famiglia italiana che in un anno utilizza 3kg di caffè?
- Una confezione di caffè in chicchi da 1 kg costa 20 euro e permette di preparare circa 150 tazzine di espresso. Le capsule, invece, costano in 0,35 euro l’una. Quale conviene di più?
- Se l’italiano medio beve circa 600 tazze di caffè all’anno, quanti kg di caffè vengono consumati in Italia in un anno (considera che ogni kg fa circa 150 tazze)?
Spunti di discussione
- Osserva le etichette di diversi tipi di caffè. Quante riportano informazioni sulla provenienza? Quante sono certificate “Fairtrade” o “biologiche”? Pensi che queste certificazioni siano importanti? Saresti disposto a pagare di più per un caffè etico? Quanto?
- In molte culture il caffè è un momento sociale. Come cambierebbe la nostra società se il caffè non fosse mai arrivato in Europa? Quali altre bevande potrebbero aver preso il suo posto nelle nostre abitudini quotidiane?
- Le capsule di caffè stanno diventando sempre più popolari per la loro praticità, ma hanno un impatto ambientale significativo. Discuti i pro e i contro delle diverse modalità di preparazione del caffè dal punto di vista ambientale.
Attività creative
- Il profumo del caffè: Annusa un caffè appena aperto, chiudi gli occhi e disegna forme e colori ispirati dalle sensazioni che il suo profumo ti evoca.
- Esploratore di sapori: Scrivi una descrizione coinvolgente del caffè per chi non l’ha mai assaggiato, usando parole evocative e paragoni originali. Quali parole useresti? A cosa lo paragoneresti?
- Progetta la tua caffettiera: Immagina di poter inventare la tua macchina del caffè ideale: come funzionerebbe? Userebbe il vento? L’energia solare? Avrebbe forme strane o suoni curiosi? Prendi carta e matite e disegnala.
- Filiera sostenibile: Immagina di essere un inventore e progetta il “sistema di produzione del caffè perfetto”, dall’albero alla tazza, che sia completamente sostenibile. Che materiali useresti? Come arriverebbe fino a noi?
- Nuovi usi creativi del caffè: Inventa un nuovo modo di usare il caffè che non sia berlo! Potrebbe essere una ricetta, un gioco, un’opera d’arte, o qualsiasi idea ti venga in mente.
- Ambasciatore dell’equo: Realizza un cartellone, volantino o presentazione per sensibilizzare sull’importanza del caffè equo e solidale.
- Caffè filosofico: Organizza un “Caffè Filosofico”, dove ognuno prepara una domanda stimolante legata al caffè o ispirata da esso (es. “La tradizione è importante o dovremmo sempre cercare l’innovazione?”, “Il commercio equo è davvero equo?”). Servite bevande “da caffetteria” e discutete le domande come si faceva nei caffè letterari del ‘700!
Risorse
- Caffè — Wikipedia — Una panoramica completa sulla storia, la cultura, la botanica e la diffusione del caffè nel mondo.
- Storia del caffè — Wikipedia — Un approfondimento dedicato all’evoluzione storica del caffè, dalle origini ai giorni nostri.
- Coffee preparation — Wikipedia (EN) — Articolo molto dettagliato sulle diverse tecniche di preparazione del caffè, le attrezzature e i metodi utilizzati a livello internazionale.
- Harold McGee, Il cibo e la cucina. Scienza, storia e cultura degli alimenti — Un’enciclopedia del cibo che esplora la storia, la scienza e la cultura della cucina, con approfondimenti sulle caratteristiche molecolari degli alimenti e una sezione dedicata al caffè.